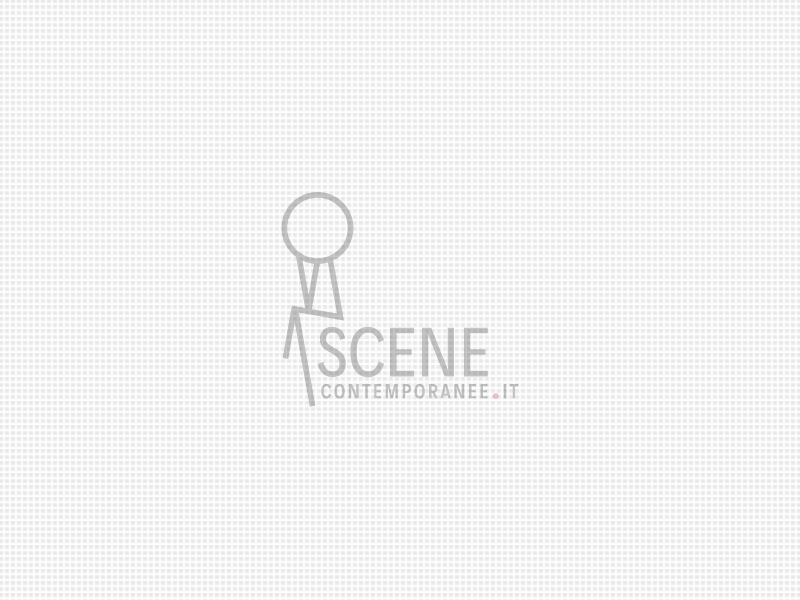Intervista a Quirino Principe
Musicologo, traduttore, saggista e penna graffiante del Sole 24 ore, Quirino Principe ha insegnato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, all’Università di Trieste e all’Università di Roma Tre. Lo incontriamo a Verona nella sede di Verona Accademia per l’Opera Italiana, dove è docente dei Master di Regia, Scenografia e costume e Composizione per il teatro d’opera.
Musicologo, traduttore, saggista e penna graffiante del Sole 24 ore, Quirino Principe ha insegnato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, all’Università di Trieste e all’Università di Roma Tre. Lo incontriamo a Verona nella sede di Verona Accademia per l’Opera Italiana, dove è docente dei Master di Regia, Scenografia e costume e Composizione per il teatro d’opera.
Quando ha cominciato a occuparsi del rapporto tra musica e arti figurative?
Questa relazione mi ha sempre affascinato. Ho sempre intuito che ci fosse un rapporto di stato d’animo tra la pittura e la musica. Quando ero un giovane studente dell’ultimo anno di liceo cominciai ad apprezzare la pittura impressionistica, Debussy e la poesia di Verlaine. Attraverso essa risalii alle liriche di Fauré e Debussy, e ascoltandole mi venne il desiderio di guardare i libri con le riproduzioni delle pitture impressionistiche con il tema della città sotto la pioggia. In quel momento capii che c’era molto più di un rapporto sensitivo ed epidermico: qualcosa esigeva approfondimento. Molti anni dopo, quando lavoravo per l’editore Rusconi, mi arrivò tra le mani una serie di scritti di Marius Schneider, ed ebbi l’idea di farne un libro, con il permesso dell’autore. Schneider scrisse il famoso Pietre che cantano, dove compare il celebre episodio di una visita alle chiese della Catalogna, in cui egli scoprì che le pietre dei capitelli delle colonne erano concepite come scale musicali, cioè riproducevano in linguaggio enigmatico la successione di suoni musicali corrispondente al numero dei lobi dei capitelli. Da allora mi immersi in questi argomenti e non ne uscii più.
Lei ha collaborato con la Fondazione Longhi. Ci racconta questa esperienza?
La Fondazione Longhi è uno di quegli enti “luminosi” su cui la mannaia dei tagli, in questo caso regionali e comunali, ha fatto venir meno molte iniziative. Fino a due anni fa, per sei anni, all’inizio della primavera, venivo invitato dalla Fondazione a tenere una lectio magistralis per gli allievi borsisti che studiavano i rapporti misteriosi esistenti tra le arti, ed un fenomeno quasi esoterico che avviene soprattutto a Firenze. Trattai diversi argomenti, fra i quali Marius Schneider, o il rapporto tra i dipinti e gli acquerelli di Viktor Hartmann, pittore non clamoroso ma molto apprezzato da Musorgskij, e la musica di Musorgskij stesso. Trattai anche il rapporto inverso: la restituzione che c’è tra un’esposizione di musica di Mussorgsky e le invenzioni pittoriche di Kandinsky nel 1926. Si tratta di una relazione molto interessante per un pubblico che sia almeno un po’ sensibile, non solo specializzato. Un’altra delle lezioni verteva sulle famose liriche per pianoforte senza voce di Raynaldo Hahn (amico intimo di Marcel Proust e musicista importante) sui sonetti di Proust, che a loro volta erano ispirati da altrettanti dipinti di pittori olandesi. Quindi, andando a ritroso: dalla pittura olandese dell’epoca tardo barocca all’ispirazione poetica del giovane Proust (che, come pochi sanno, scrisse molte belle poesie), a Hahn che negli anni Trenta compose alcune musiche riproducendo la poesia che a sua volta riproduceva moduli e canoni pittorici dei maestri fiamminghi.
Lei si è anche occupato di miniature medievali e del loro rapporto con la musica e la letteratura.
Fra le arti della visione, quella che mi tocca più da vicino è proprio la miniatura, che mi riporta alla grande poesia dei secoli che più amo, cioè il XII e il XIII, XIV secolo (sia la poesia francese che quella tedesca, e naturalmente quella italiana di Dante e degli stilnovisti). Nel 2010 è stato pubblicato da Marsilio un libro su musica e arti figurative, con interventi di circa trenta importanti autori ciascuno dei quali tratta un aspetto del rapporto tra musica e pittura, architettura e scultura. Nel mio saggio in apertura del volume individuo un numero segreto che identifico come modulo comune alle esperienze artistiche che rappresentano una sensazione, una realtà naturale, quella del freddo, del gelo.
Com’è nata questa idea?
Quando ero ancora al liceo, studiai le rime petrose di Dante Alighieri. Le canzoni “Io son venuto al punto de la rota” e “Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra” descrivono il progressivo raggelarsi del pianeta d’inverno, ma questo gelo, dice Dante (secondo una certa metafora cara alla retorica antica, per cui il fuoco è l’amore, l’eros, mentre il gelo è l’indifferenza), non riesce a gelare la mia passione per la donna “Pietra”, il contrario della donna angelica, cioè Beatrice. In questa visione si parla di un paesaggio nevoso con due grandi colli molto alti, di uguale altezza, dove la neve ha completamente cancellato e coperto l’erba verde che c’era in primavera. Su questa visione Dante costruisce un discorso affascinante, ma che soltanto a grattare un po’ si rivela di un erotismo molto spinto: della donna Pietra dice “vorrei dormire in pietra, su pietra” e “preferirei pascere l’erba”, mentre gli altissimi colli rappresentano chiaramente il seno di una donna. Il tutto è castissimo, meravigliosamente elegante e senza alcuna traccia di volgarità, ma questo dà la prova che esiste in Dante una forte venatura, come è stato detto, di eros spinto, che molti hanno cancellato durante la storia della critica dantesca, secondo una visione di Dante pienamente ortodossa (a parte il fatto che Dante è stato dimostrato essere stato un eretico cátaro, ormai su questo non ci sono dubbi, dopo l’importante monografia di Maria Soresina su questo tema).
E la miniatura?
Qualche tempo dopo, mentre frequentavo l’università, guardando il famoso libro d’ore del duca di Berry con le miniature dei due fratelli Limbourg (forse il più bel libro miniato della storia d’occidente), osservai che le miniature raffiguranti la tenuta aristocratica del duca di Berry nei vari mesi, da gennaio a dicembre, rappresentano il mese di febbraio come mese invernale. Mentre le miniature di tutti gli altri mesi sono piene di colori rutilanti (anche dicembre è un mese festoso, novembre è il mese pieno di vino e di gente che beve, pieno di stendardi, bandiere e finestre istoriate), nel mese di febbraio si vede un paesaggio nevoso. In quella miniatura ho riconosciuto con stupefazione i due colli nevosi, un ciuffo d’erba e delle scene di vita di uomini e animali. Dante certamente non poteva conoscere le miniature dei Limbourg perché morì un secolo e mezzo prima della loro nascita, ma è anche difficile che due miniatori fiamminghi conoscessero la Divina Commedia, o addirittura le rime dantesche (quelle rime in particolare furono conosciute grazie ai Memoriali Bolognesi scoperti da Carducci alla fine dell’Ottocento). Ne dedussi che si trattava di un fatto di sensibilità comune, non filologico o d’ispirazione, ma più strutturale. La rima petrosa di Dante “Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra, son giunto, lasso, ed al bianchir de’ colli, quando si perde lo color ne l’erba”, dove si parla di questi due alti colli nevosi, è una sestina, la forma più difficile dal punto di vista metrico, inventata dal trovatore provenzale Arnaud Daniel. La sestina è composta da una serie di strofe di sei versi ciascuna, dei quali ognuno termina con una parola diversa. La seconda strofa riprende queste stesse parole collocandole, rispetto alla prima strofa, nel seguente ordine: ultima/prima, penultima/seconda, terzultima/terza. La terza strofa ripete lo stesso gioco rispetto alla seconda strofa e così via. Alla fine della sesta strofa se noi ripetessimo il gioco di variante saremmo alla successione della prima strofa. Ma di solito, anche nel caso di questa rima dantesca, la sestina si ferma alla sesta strofa per non dover ripetere il gioco. C’è dunque un’ossessione per un numero, il sei. Notai che nella miniatura dei fratelli Limbourg il numero sei è ossessivo: ci sono sei gruppi di esseri viventi e sei locations, e la cosa mi sembrò clamorosa. L’ossessione di questo numero sei si collega sia nella poesia di Dante sia nella miniatura dei Limbourg all’idea del gelo, un concetto insolito nella poesia tra il Duecento e il Quattrocento, dove si preferisce usare il locus amoenus e parlare della primavera. Lo stesso avveniva nella pittura (pensiamo a Botticelli e al primo Rinascimento) e nella musica.
Qualche esempio?
Cercai dunque una spiegazione anche nella musica, e scoprii che Henry Purcell nell’opera King Arthur sperimenta una scena allora inedita, quella del gelo: l’esercito di Re Artù rimane intrappolato nel ghiaccio e i cavalli non possono correre perché un lago ghiacciato sotto di loro imprigiona gli zoccoli. Questa scena è frequente in un poeta moderno: dopo il Romanticismo il gelo, il ghiaccio, la tempesta e le intemperie (pensate a Jules Verne o a Stevenson in L’isola del tesoro) sono qualcosa di bello a descriversi, ma prima era abbastanza insolito. Come ha realizzato Purcell la scena del gelo? Con degli accordi vuoti, senza la nota intermedia ma utilizzando solo prima e sesta. Sono tutti accordi di sesta, e ho capito che gli accordi vuoti di sesta se non sono rimpolpati dalla terza danno l’idea del gelo. Provai con un autore moderno, analizzando il “prélude” che reca in calce il quasi-titolo Des pas sur la neige (Passi sulla neve) di Debussy, e anche lì trovai il dominio dell’intervallo di sesta. Capii quindi che nel numero sei c’è un segreto che va al di là dei singoli linguaggi artistici, un segreto cosmico, in cui è contenuta questa nostra relazione con la natura che noi chiamiamo freddo, gelo, ghiaccio.
Anche recentemente lei si è occupato di Wagner. Ci parla della mostra su Wagner e le arti recentemente conclusa a Palazzo Fortuny a Venezia?
Il tema fondamentale della mostra è l’incontro delle varie arti in un luogo deputato, cioè il teatro d’opera. Nella storia l’Occidente ha avuto la grande intuizione di riunire tutte le arti e tutti i talenti relativi alle varie arti in questo straordinario specchio che solo l’occidente possiede. Alcuni autori del teatro d’opera, Wagner soprattutto, hanno teorizzato come necessaria e irrinunciabile questa convergenza che deve essere il più possibile piena e perfetta. Tale convergenza si può raggiungere meravigliosamente quando l’autore del testo, della musica, delle scene, dei costumi e il regista sono la stessa persona. Questo spiega perché Wagner riesce a essere poeta e musicista di se stesso. Per la scenografia affidò a Paul Joukowsky, un intimo amico, che lavorò per alcune delle sue opere e fu lo scenografo non prediletto ma unico di Wagner (e per questo subì delle critiche). Per quanto riguarda l’illuminotecnica ,Wagner non poté conoscere il grande Mariano Fortuny.
Cosa era esposto nella mostra?
Nella mostra sono esposte le opere di Fortuny, dalla pittura, all’arredamento, alle stoffe, ai tessuti (si pensi a Proust che parla di Fortuny in à la recherche du temps perdu, e ,al personaggio di Albertine per la quale Marcel sceglie un capo d’abbigliamento tagliato su un tessuto prodotto da Fortuny). Proprio da qui deve nascere un richiamo all’importanza dell’estetica occidentale, che a differenza di altre aree geografiche non sopporta pregiudizi di carattere etico. L’estetica cinese per esempio (c’è molta Cina anche nell’estetica di Fortuny: la calligrafia, il rapporto tra le masse di colore) è sempre in funzione di una vita buona e onesta. Nell’estetica occidentale l’artista di genio non ha bisogno di essere né giusto, né buono, né onesto.
E Wagner?
Il caso di Wagner è emblematico: se c’è stato un cattivo marito, un pessimo amante, un padre insopportabile, un uomo pieno di sé, egoista etc., quello è stato proprio Wagner, ma ciò non ha importanza, poiché siamo di fronte a un’alta espressione di genialità. Che poi questa mostra avvenga a Venezia è particolarmente significativo. È la città in cui Wagner non è soltanto morto ma ha composto lavori meravigliosi come il secondo atto di Tristan und Isolde, ed è sempre stata nei sogni di Wagner sin da prima che egli ci abitasse. Il fatto che la mostra sia allestita nel museo di Fortuny ci ricorda anche la presenza di un grande scrittore come Proust. C’è una sorta di triangolo: Wagner nell’anno nel centenario, l’arte di Mariano Fortuny, che a Venezia si manifesta non solo nelle arti maggiori ma anche in quelle applicate cosiddette minori (capaci di raggiungere proprio qui un’eccellenza universale) e Proust, lo scrittore che di questo ha dato testimonianza nella Recherche offrendoci la guida per poter collegare e capire la poetica wagneriana e quella di Fortuny. E ciò avviene con un “sigillo” veneziano, perché Fortuny fu anche un interprete del comun denominatore dell’arte di questa città e c’è sempre Venezia nei suoi tessuti e nei suoi colori. Venezia diventa quindi il suggello di questa ideale trigonometria.